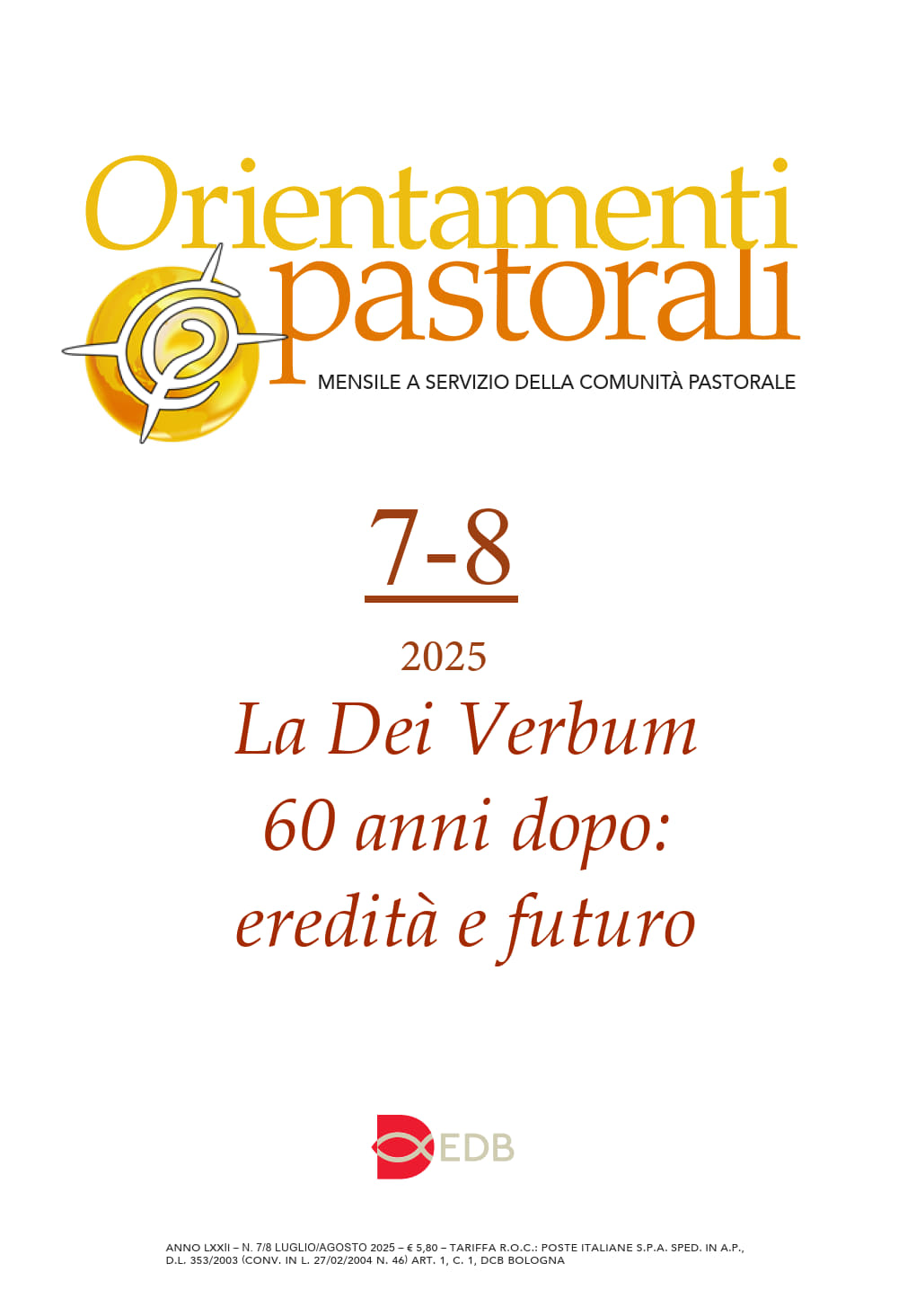
Il lungo cammino ecclesiale, biblico e teologico del Novecento, che ha portato al Concilio Vaticano II, ha nella Dei Verbum uno degli esiti più visibili e più importanti. La Costituzione dogmatica sulla centralità della Parola di Dio, il cui lavoro di stesura e approvazione fu lungo e travagliato fino al 1965, rappresenta una vera e propria svolta nella teologia della Rivelazione e una pietra miliare dell’assise conciliare. Superando un’impostazione eccessivamente intellettuale e dottrinale, Dei Verbum presenta la Rivelazione di Dio come un evento dinamico centrato sulla relazione tra Dio e l’umanità in Cristo.
Vera svolta della Dei Verbum può essere considerato il capitolo 6, in cui tra le altre cose si afferma che La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per il Corpo stesso di Cristo la Chiesa onora le Scritture» (n. 21). La Scrittura, dunque, è presenza di Cristo come lo è l’Eucaristia anche se questa consapevolezza non è passata nel Popolo di Dio, che continua a considerare la Scrittura come un aspetto che riguarda la dimensione conoscitiva del cammino di fede e non come reale presenza del Signore con cui entrare in dialogo. La Verbum Domini, decenni dopo, ha ribadito la sacramentalità della Parola. Su questo tema, 60 anni dopo, c’è ancora molto da fare.
La Rivelazione biblica, che ha il suo centro e culmine nell’incarnazione di Cristo, si presenta nella Scrittura come l’offerta di un dialogo che Dio inizia con l’umanità e che attraversa le vicissitudini della storia al fine di condurla alla figliolanza divina, all’incontro col Padre e alla pienezza della vita eterna. Nel nostro contesto multiculturale e multireligioso, questo progetto al quale il cristiano aderisce nella fede è chiamato a confrontarsi con le altre pretese di salvezza e con quelle rivelazioni che hanno dato origine ad altre espressioni religiosi. Oggi occorre ancora una volta chiedersi: quale relazione tra la rivelazione cristiana e quella ebraica e quindi fra i due Testamenti? Tra la rivelazione cristiana e l’Islam? Tra cristianesimo e altre fedi e religioni?
Il comune cristiano o, per dirla con Karl Rahner il cristiano ordinario, è in realtà la vera sostanza della Chiesa, dal momento che nella comunità cristiana non tutti sono specialisti, tecnici, teologi, preti e così via. E la Scrittura parla, circola, fruisce anzitutto nel cammino feriale dei credenti e delle Comunità. Quali problemi pone, oggi, l’ascolto e l’interpretazione della Scrittura? Qual è la percezione del fedele “medio” dinanzi ad alcune espressioni e/o visioni bibliche?
A sessant’anni da Dei Verbum e nonostante l’importante cammino ecclesiale per rimettere al centro la Scrittura, rimane sempre attuale il problema della interpretazione e comunicazione della Parola. Non si tratta soltanto di un contenuto letterario o esegetico, ma si tratta sempre di comunicare la fede e il messaggio di salvezza che Dio vuole donarci, una comunicazione che implica la totalità della vita del comunicatore nella costante relazione con i suoi destinatari. Ciò significa che la Scrittura, che nasce in un contesto di comunione e accade nella storia reale, deve sempre essere interpretata in questa cornice relazionale e storica. La storia, intesa come luogo teologico della rivelazione e la relazione reale con il destinatario di oggi ci evita il rischio di letture letterali, integraliste, fondamentaliste e ideologiche, come già la pontificia commissione biblica ci ha esortati a fare in questi anni.
Tante e diverse sono le forme di annuncio della Parola e le vie per conoscere e meditare le Scritture. A fronte di un certo impulso postconciliare, che ha rimesso la Sacra Scrittura al centro della vita della chiesa, oggi assistiamo ad una partecipazione ecclesiale che diventa sempre più rarefatta e frastagliata: pochi sono gli operatori pastorali e i credenti impegnati, molti altri restano sulla soglia e casomai partecipano soltanto alla domenica. In tale situazione per molti l’omelia è l’unica occasione per entrare a contatto con la Scrittura. Ma come preparare l’omelia? Quali elementi biblici, quali linguaggi, quale stile? E qual è lo scopo principale dell’omelia, che si differenzia dalla catechesi, dalla lectio o da altre forme di annuncio?
Dopo 60 anni da questo Documento spartiacque, la sua eredità ci chiede di affrontare anche alcune tematiche connesse che oggi sono diventate più attuali e urgenti, così come ci chiede di non soprassedere su alcune problematiche o criticità: abbiamo davvero reso “onore” alla centralità della Scrittura nella Comunità cristiana? Come si pone la rivelazione biblica del Dio di Gesù Cristo in rapporto alle altre rivelazioni e religioni? Quale interpretazione della Scrittura oggi?
In questo numero contributi di Gianluca Montaldi, Francesco Cosentino, Giuseppe Savagnone, Giuseppe De Virgilio, Gianni Mazzillo
